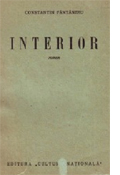|
|
Constantin Fântâneru, «il Salinger romeno». Inedito dal romanzo «Interno»
 Constantin Fântâneru (1907-1975) è il grande dimenticato e il grande solitario (a ragione gli è stato affibbiato l’appellativo de «il Salinger romeno») della straordinaria stagione letteraria romena del periodo interbellico, uno scrittore avvolto – o che, per meglio dire, si è voluto avvolgere – nel mistero ma che rappresenta la primissima voce, la punta di diamante di quella generazione di intellettuali e di giovani scrittori (E. Cioran, M. Eliade, E. Ionescu, M. Blecher ecc.) che proprio in quello scorcio di secolo cominciavano a tracciare un solco di rinnovamento nella cultura e nella prosa romena del ’900. Constantin Fântâneru (1907-1975) è il grande dimenticato e il grande solitario (a ragione gli è stato affibbiato l’appellativo de «il Salinger romeno») della straordinaria stagione letteraria romena del periodo interbellico, uno scrittore avvolto – o che, per meglio dire, si è voluto avvolgere – nel mistero ma che rappresenta la primissima voce, la punta di diamante di quella generazione di intellettuali e di giovani scrittori (E. Cioran, M. Eliade, E. Ionescu, M. Blecher ecc.) che proprio in quello scorcio di secolo cominciavano a tracciare un solco di rinnovamento nella cultura e nella prosa romena del ’900.
Nato in un piccolo villaggio, Glodu, che l’autore, con sottile ironia, definiva come «uno dei villaggi più modesti» che conoscesse, anche se altrove afferma di essere originario di una località diversa, Leordeni – si trasferisce in seguito a Bucarest per studiare nel Collegio «Sf. Sava» dove avrà come compagno, fra gli altri, Ionescu. Nel 1932 (o 1933), a venticinque anni, debutta in prosa con il romanzo Interior («Interno»), che resterà il suo unico romanzo, accanto alle altre due opere pubblicate in vita (postumi sono tutti gli altri suoi testi; i due volumi di più recente pubblicazione, che raccolgono le sue sparse annotazioni, Jurnale [«Diari»], sono del 2012) e sono il volume di critica Poezia lui Lucian Blaga și gîndirea mitică («La poesia di Lucian Blaga e il pensiero mitico») e la raccolta poetica Rîsul morţilor de aur («Il sorriso dei morti d’oro»), entrambi pubblicati nel 1940. La pubblicazione del suo romanzo viene accolta quasi con unanime entusiasmo dai critici letterari più autorevoli (come George Călinescu) e da scrittori che in esso si rispecchiavano o che vi ravvisavano un sentire comune (A. Holban, M. Eliade, M. Sebastian, E. Ionescu ecc.). Ma la sua fama letteraria sarà tanto folgorante quanto effimera poiché negli anni a seguire viene a isterilirsi in lui lo stimolo a continuare a scrivere – assorbito invero dall’attività come redattore, nel 1935, presso il quotidiano «Prezentul», e un anno dopo, presso «Universul», e ancora, tra il 1938 e il 1941, come capo redattore e recensore di libri per «Universul literar»– ritraendosi in un anonimato nel quale scivolerà lentamente nell’isolamento, conseguenza diretta di una forma mentale e di un carattere inclini allo smarrimento e all’autocommiserazione – aggravati da un calamitoso rapporto amoroso e da disturbi psichici – che contraddistingueranno la sua esistenza fino alla fine dei suo giorni.
E così, infatti, Constantin Fântâneru semplicemente si eclisserà in maniera definitiva dal mondo, dimenticato da tutti (nel 1969 si pensava che fosse addirittura già morto quando invece non lo era affatto!); si autoreclude, scegliendo di essere un anonimo e povero professore di campagna, nella sua Glodu, in condizioni al limite dell’indigenza. Solo verso gli ultimi anni di vita, ha uno scatto di orgogliosa vitalità: progetta di tornare sulla scena letteraria con altri scritti: purtroppo lo coglierà già la morte.
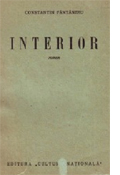 (Copertina della prima edizione: Editura Cultura Naţională, Bucarest, 1933) (Copertina della prima edizione: Editura Cultura Naţională, Bucarest, 1933)
Interior è l’Ur-romanzo della poetica del fanciullo-adolescente (com’è il protagonista, il ventenne Călin Adam) disorientato, emarginato e dall’identità incerta e smarrita, insofferente del mondo «adulto» e delle regole da esso imposte, che si sgancia dalla realtà per vagare in una dimensione fuori da essa, sperimentando nel suo «interno», nel suo «profondo» nuove avventure e sensazioni che egli può gustare solo in questa forma di quasi allucinante anarchia mentale. In esso si trovano in nuce temi che Max Blecher – altro illustre rappresentante del periodo d’oro letterario interbellico, colui che raccoglie in un certo senso il discorso umano e poetico di Const. Fântâneru – catturerà sotto altri aspetti, e con un gusto stilistico assai diverso, nei suoi Accadimenti della realtà immediata, romanzo pubblicato nel 1935 (e proposto recentemente per la prima volta in traduzione italiana da Bruno Mazzoni presso l’editore Keller).
Per dare la misura dell’importanza storica e dell’eccezionalità del romanzo di Fântâneru, ci sembra quanto mai utile e opportuno proporre un passaggio dall’ottimo e dettagliatissimo studio introduttivo firmato da Simona Popescu (da cui abbiamo tratto le informazioni per questa presentazione) che così recita: «Interior è il nostro capofila della letteratura che narra “della bizzarra avventura di essere uomo”, secondo la memorabile definizione formulata da Blecher alcuni anni dopo: letteratura che narra le emozioni metafisiche (legate alla corporalità), l’esistenza fatta corpo della scrittura, la “zona crepuscolare”, la marginalità e gli emarginati. Ma che di tutto questo avesse scritto, anticipando tutti, Fântâneru lo si è, purtroppo, dimenticato. Il suo libro è molto più ambizioso di quanto intuissero i suoi contemporanei (per non parlare della cecità degli smemorati posteri) e, a differenza della prosa degli altri colleghi della sua generazione, profondamente poetico».
Il frammento che si può leggere qui di seguito, l’incipit, offre per la prima volta in traduzione italiana un assaggio di questo romanzo; va menzionato inoltre il fatto che la prima e unica traduzione del romanzo, in spagnolo e pubblicata nel 2011, la si deve a Rafael Pisot e Cristina Sava che hanno così sottratto a un immeritato oblio questo romanzo e reso, letterariamente parlando, meritata giustizia al suo autore, l’enigmatico e misterioso Constantin Fântâneru.
Da «Interior» («Interno»)
Più tardi venne da me in camera Cati, la figlioletta della padrona di casa. Si fermò sull’uscio; mi limito a girare la testa e la vedo dal tavolo di metallo.
«La mamma mi ha detto di domandarle quando intende pagare l’affitto» disse.
Aprii un libro e vi lessi alcune righe; lo richiusi; non distinguevo né le lettere, né la pagina; il libro si dissipò fantasmagoricamente in un frullio di magnifiche visioni assieme a tutto il resto.
«Quando intendo pagare» ripeto e raddrizzo la schiena appoggiandomi alla spalliera della sedia. Mi dolevano le spalle per la concentrazione, per l’umiliazione.
«Di’ alla signora che sono umano» dico io atteggiando un finto cinismo e mi metto a camminare con le braccia incrociate, passando sotto il drappeggio delle finestre. La ragazza aspetta sull’uscio, con aria incerta. I fiori nel vaso erano appassiti e non me ne ero accorto. «Questo non me lo posso perdonare» dico divagando e guardai la ragazza con un sorriso.
«Vedi, cara Cati, ho dimenticato di dar da bere ai fiori, i miei diletti fiori!»
Per un istante Cati si distrasse; gli occhi neri come il carbone si avvicinarono a me, sotto sulle guance balenò delicatissimo un fulgore. Le risultava gravoso parlarmi. Mi fermai di nuovo al centro della stanza.
«Di’ alla signora che aspetto la primavera» dico come in precedenza, in delirio, «aspetto la primavera!»
Estenuato, risolvo infondermi coraggio. Cati uscì quindi senza una risposta certa. Mi metto il cappotto, infilo in tasca un libro; colto dalla consueta avventatezza getto tutt’intorno alla stanza uno sguardo e varco la soglia.
È un mese di marzo chiazzato qui e là di nuvole; la luce giallognola pulsa nella vastità. Alcuni uccellini frullano tra gli albicocchi, lì vicino! Mi elettrizza il sereno ammiccamento di un cielo sotto forma di una tela di zaffiro. Di nuovo la vita si tesse, come ogni giorno, con provocatoria forza. Alzo la fronte al languido cielo. Io e lui, veri miti che sorridono come due Arlecchini. Vivo risuscitato da una vergognosa tristezza, da una disperazione a volte irrimediabile, dopo intervalli d’ingenuità, come un’Araba Fenice degradata.
C’è un ampio cortile costeggiato fino in strada da due file di case. La mia camera, angusta, dà su un giardino pieno di fiori. Accanto alla finestra crescono delle giovani acacie, dall’aspetto selvatico. Dopo l’acquazzone mattutino, le pozze sono andate ingrossandosi. Il cortile ostentava un’aria di misera e pittoresca meschinità per via dell’infantile scompiglio degli edifici, dell’ilare mescolanza di persone e animali. I cani sollevavano reciprocamente i lanuginosi musi, sbrodolandosi d’aria. Diressi l’attenzione verso l’intrico di edera abbarbicata alla veranda, attorcigliata al collo delle colonne di legno. Presto rinverdirà, pensai; il poggiolo tornerà a sorridere e il cortile rinnovato in sé emanerà un suo fascino pittorico, in questa periferia. Tempo fa, in autunno, quando giungevo a casa tardi, la luna dopo mezzanotte cadeva sui vetri della finestra. Le pareti venivano cosparse di una luce lattiginosa, l’astro trasudava sui tetti come polpa di un melone fracassato. Il ricordo mi assedia. Vedo tettoie deserte, basse, ricoperte di tegole rosse, con gronde che si protendono nella notte come fossero delle mani.
Il cortile conduce in via Griviţa. Lo attraversai di corsa, poiché mi potevo incontrare con la padrona di casa. Ultimamente i nostri rapporti non erano stati buoni; non le avevo pagato l’affitto. Mi sforzavo umilmente di farle intendere che non era per via di gaudenti smodatezze che non riuscivo a sdebitarmi con lei. Il mio aspetto, di tutta evidenza, poteva esserne la prova. Portavo gli stessi indumenti che mi aveva visto indosso fin da quando mi sistemai da lei e la mia vita di giovane l’avevo ridotta al pari di un animale macilento. Non ricevevo visite, né incontravo gente. Vivevo in solitudine, così, in compagnia di qualche libro; uscivo di casa, invero, all’ora del desinare, trascinandomi lungo giornate monotone, laide!
Gli ultimi tempi li passai soprattutto in città; il denaro racimolato con difficoltà per poter traslocare sta per finire. Cammino per strada perennemente preoccupato dal che fare. Abbandonare la Capitale, vagare per il Paese, con un impeto nuovo di errabondo: mi tenta quest’idea come molte altre.
Un giorno mi fermo davanti a un manifesto e mi sforzo invano di capire ciò che c’è scritto. Un anno prima si era spostato per il Paese un circo, uno famoso, e non so perché ma ho come l’impressione che il manifesto sia resistito lì in ricordo di quegli animali. Le fortunate fiere avevano già lasciato un luogo che per me cominciava a essere un supplizio.
-Buongiorno!
Giro la testa; è lei, Azia. Ricambio il saluto a voce più bassa. Sono livido in volto e non voglio in alcun modo che scopra cosa turbi la mia mente.
-Che splendida giornata, dice lei.
Ho intenzione di stare incollato per un po’ di tempo al pannello dei manifesti. Me ne rimasi lì con le braccia addossate lungo il cappotto logoro, guardando davanti. D’un tratto però sono colto da un terribile moto di disgusto. Azia mi domanda qualcosa, non so riguardo a che cosa, imbarazzata. Di coraggio, null’altro di coraggio avevo bisogno. E in effetti ho l’ardire di guardare la ragazza negli occhi, con fervore. Ha lo sguardo grave con cui mi misura dall’alto in basso. Mi lasciai scrutare, mentre la ripugnanza svaniva via da me e una strana gioia m’invase. Ora come ora, perché non vedere in Azia un’amica? Di colpo mi venne voglia di conversare; poco prima aveva accennato al bel tempo. Il cielo era come il mare verso il meriggio; un mare spruzzato d’astri. Quel suo rarefatto azzurro era umido e caldo. Mi si scatenò il cuore, gridavo a squarciagola per confermare il vigore delle mie sensazioni, per inebriarmi da solo della magia del giorno!
-Eri esattamente così anche la volta scorsa, disse Azia.
-Vero, risposi; da un po’ di tempo a questa parte sono esattamente così.
-Sei una persona curiosa.
-È il tempo che mi ha reso curioso, molto curioso.
Mi accorgo di balbettare mentre pronuncio queste parole. Azia non si scosta da me. Dio, che troverà in me, mi domando stupito; non oso muovermi per paura d’indispettirla. Ho la mente limpida. Mi sto forse innamorando di lei?, perché ogni momento che passa mi sembra più bella di prima.
-Verso dove stai andando? le domando.
Evitò di rispondermi, ma mi fece notare che ero ridicolo stando attaccato al muro tappezzato di manifesti. Mossi qualche passo in avanti per avvicinarmi a lei.
-Non ti senti in imbarazzo a chiacchierare con me? dico fatuo. Lei di colpo si scompose in viso. A malapena riuscì a trattenersi.
-Per il momento non ti do alcuna spiegazione, disse lei ironica e girò intorno a me perché io vedessi che era solo la fantasia a trattenerla lì! I suoi capricci mi erano noti già in precedenza. La gioia che s’irradiò, diffondendosi repentina sul mio volto, la fece trasalire, mutando il suo stato d’animo.
-Mi puoi accompagnare, se vuoi, disse
Giudico questo invito come un mio misterioso trionfo e replico:
-Grazie, sei molto gentile.
C’incamminammo giù per il viale. D’altronde ardevo dal desiderio di conoscere il maggior numero di cose sul conto di Azia. In quale parte della città abitasse, se vivesse tutta sola o presso qualche parente. Mentre conversavamo, Azia fu assalita da una gioia insolita. No, non abita presso parenti, stava in una camera presa in affitto che ha ammobiliato secondo il suo gusto. Le manca ancora per finire gli studi; è una studentessa ligia alla libertà!
-Tu non ami la libertà? mi domanda da scolaretta.
-Come no, replicai annuendo con semplicità.
Sembrava che fossimo dominati entrambi da un tacito entusiasmo e che ci esplodesse solamente negli occhi. Esordivano istanti di felicità, di profonda felicità.
Infilai le mani nelle tasche del cappotto e, senza abbottonarmelo, camminavo scrollando le spalle.
-D’ora in poi non sarò più solo, risposi con riconoscenza.
-In effetti, hai un aspetto da selvaggio.
Prendemmo a destra, entrando in un giardino pubblico. Sul laghetto d’acqua trasparente ondeggiavano gli amenti dei salici, disegnando cerchi concentrici. Girammo attorno al laghetto; per la prima volta, in primavera, scorgo una minuscola farfalla bianca. Mi tolsi rapidamente il cappello; mi precipitai per catturarla. Il cuore mi batte per la felicità; tutto il sangue era fluito alle guance; invano però, perché la farfalla si era involata rapida sul laghetto. Tornato in me, da una mano mi gocciolava del sangue limpido, rosso. Azia mi guardò in maniera alquanto curiosa.
-Se l’avessi presa, te l’avrei regalata, dico io.
-Grazie, è carino da parte tua; per un momento mi soppesò con un’attenzione straziante; poi mi tende la sua mano bianca, la posa per un minuto sulla mia e dice nervosa:
-Arrivederci.
La vidi mentre svaniva uscendo dal giardino pubblico varcando il cancello più vicino.
*
Quanto accadde mi sconfortò più di quanto potessi immaginarmi. Passarono tre giorni e sedevo nel parco su una panchina e mi rodevo le unghie per la disperazione. Ogni minuto che passava mi sfiniva, mi risucchiava le energie, sicché la testa mi girava e avevo lancinanti emicranie.
Quindi, invano avevo riposto le mie speranze in giorni più fulgidi, nella solidità della mia intelligenza. Con Azia mi ero comportato come uno squilibrato fanfarone. Che mi resta da fare? Alle volte tendo l’orecchio a un albero e sto ad ascoltare come vi sale e scende zigzagando la linfa oppure mi afferro alla sua corteccia con le dita fino a farmele sanguinare.
La voglia di vivere dentro di me è pure essa minacciata. Provo repulsione quindi per me stesso perché non riesco a trovare un’occupazione, a comportarmi convenientemente, a smettere di vagabondare come un cane bastonato nella mia propria coscienza!
Quando cammino, prendo inconsultamente a calci la terra. Vorrei urlare a squarciagola che disprezzo la gente, che non m’importa più di nulla e che tutta questa commedia popolata di Arlecchini può andare al diavolo, in un sol colpo.
Perché arrovellarmici tanto? Sobillare l’amore dei vecchi amici, attirare su di me la loro attenzione e convincerli, e così via… Che posso ancora inventarmi adesso? Sono fiero, signori, ora lo sapete, ecco tutto. In fin dei conti mi posso dispensare dalla preoccupazione, così umana, di avere un comportamento socievole, posso urlare come un animale di essere libero, di sentirmi libero fin dentro le midolla e di aver detto addio alla nostalgia di una società civile.
Siano lodati tutti gli esseri viventi e che un sole misericordioso li protegga. Un evviva anche agli olmi che mi hanno offerto la loro ombra e che sotto la corteccia ne ribollisca la profumata linfa. Mi arde il corpo di gioia, d’infinita contentezza. Placido, assente, felice!
*
Dinanzi a me, il giardino si schiude rorido, paradisiaco. Il verde corposo, il crepitio delle foglie mi sobillano i nervi. Dai cancelli fluisce gente. Solo giovani. Fanciulle dal cuore e dalle occhiate sinceri. Giovinotti eleganti le accompagnano, ridendo d’incontenibile gioia. Le prendono sottobraccio. Le abbracciano. Se solo non fosse un sogno! A pochi passi il corpo delle ragazze sussulta e odo risa luminose. I giovani si stringono come filamenti. Sembra un gemere d’acqua.
In un angolo, a sinistra, le delicate petunie mi provocano. Suggo i miei nervi assieme al loro rosso. Hanno foglie troppo grandi. Mi chino: avvicino le guance, affondandovele. I gigli bianchi, con il polline asperso sulle esili foglie lanceolate, si disgiungono in boccioli squarciati. Mi fanno male le dita perché non mi è permesso di umettarle, d’insudiciarmi i palmi delle mani, di strofinarle. Dalie e ancora dalie, a perdita d’occhio. Lo stesso voluttuoso stordimento è emanato dai tulipani. Le peonie, i giaggioli mi accecano con le loro tonalità rosa e violacee. È per me che dipingono questo quadro floreale. Accanto ci sono cespugli di ligustro e di lillà bianco e azzurro. Più su, ecco le rose, sotto la volta.
Sull’angolo della panchina su cui mi sono seduto, sono solo. La luce di una lampadina, che si diffonde sul vialetto, arriva a lambire i miei piedi. Il capo spossato si riposa placidamente, la nuca appoggiata sulla spalliera. Una brezza vivace scuote il polline degli alberelli gialli. Chiudo gli occhi. Mi lascio cullare. Sono felice. Sono avvolto da un momento meraviglioso, benevolo. Attendo che parta la musica. Nell’attesa, a petto scoperto, mi sdraio sulla panchina, come farebbe un vagabondo. Probabilmente avevo il petto gonfio e, espirando, ho rilasciato un lungo sospiro. Ho attirato l’attenzione. Sento alla mia destra:
-Guardate come si è steso quello là!
Al che fece seguito uno sbuffare di risa, uno scroscio incantevole. Girai la testa:
-Ehi, non avete di meglio da fare che importunare la gente!?
Erano tre ragazze. In mezzo a loro c’era un ragazzo. Un’altra ragazza passeggiava più in là, dondolando le braccia. Proprio a lei era saltato in mente di esclamare di come me ne stavo sdraiato. Accigliato, ne scruto la sagoma. Il suo corpo e la sua bellezza mi intrigano. È assai esile. Deve avere quindici anni. Ciò nonostante è già ben formata. Tanto infantile eppur capace di importunare la gente. Quell’esclamazione di disprezzo poteva uscire solo dalla bocca di una ragazzina avvezza a dar sorpresa. Ma le perdono se non altro. Ha inizio la musica. Scaccio via queste sciocchezze. (…)
A cura e traduzione di Mauro Barindi
(n. 3, marzo 2013, anno III)
|
|